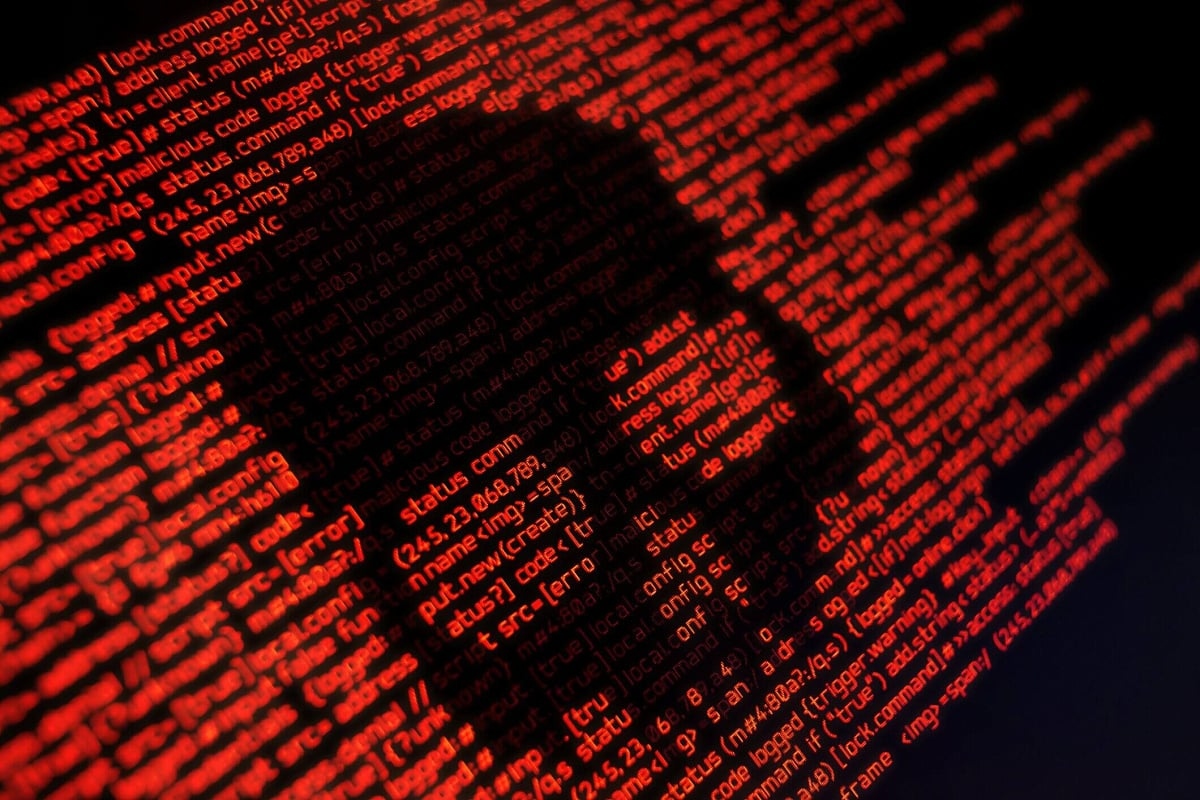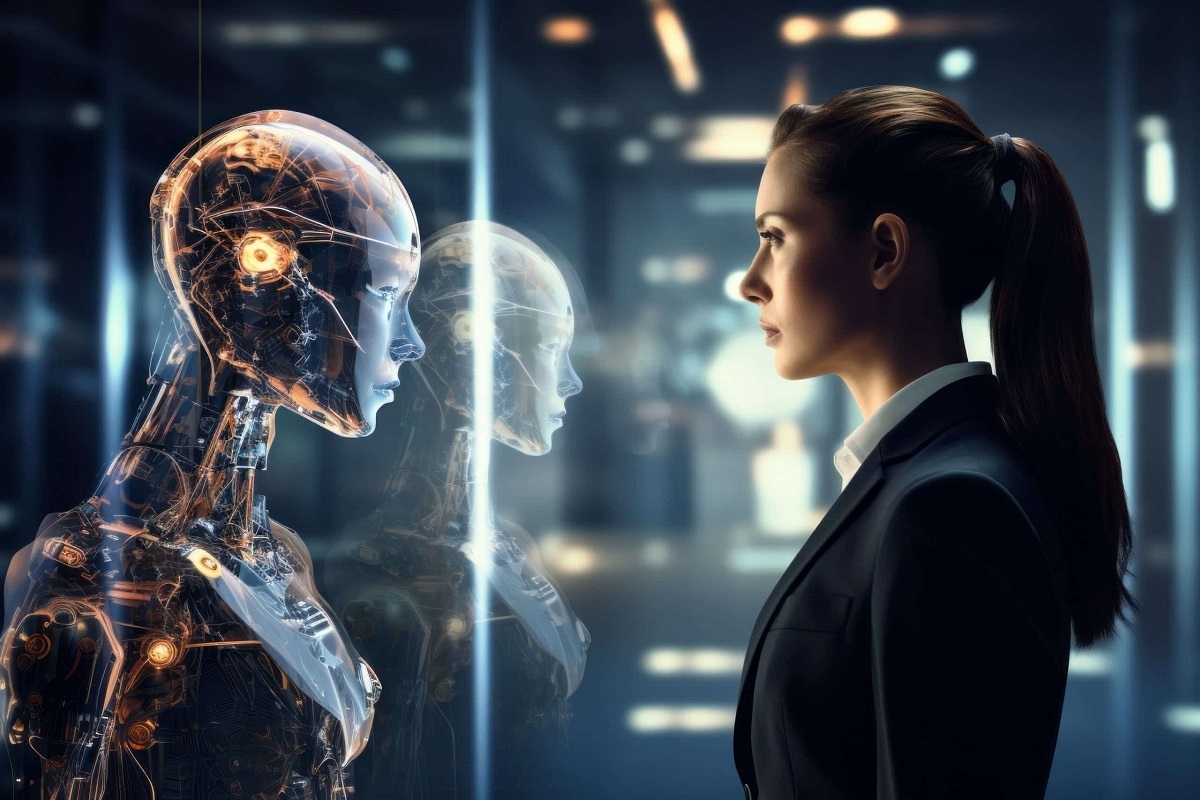È la domanda fondamentale: come è iniziato tutto? Come è possibile che su un pianeta giovane, caotico e geologicamente attivo, un mucchio di sostanze chimiche inerti si sia trasformato nella prima cellula vivente? Quello che sappiamo è che la protocellula, chiamata LUCA, ha dato inizio alla vita e l’evoluzione darwiniana ha fatto il resto, portandoci fino ai giorni nostri. Ma ci sono ancora molti dubbi sul perché tutto questo sia avvenuto.
Matematica contro il caso: perché secondo i calcoli degli scienziati la vita sulla Terra non avrebbe mai dovuto nascere
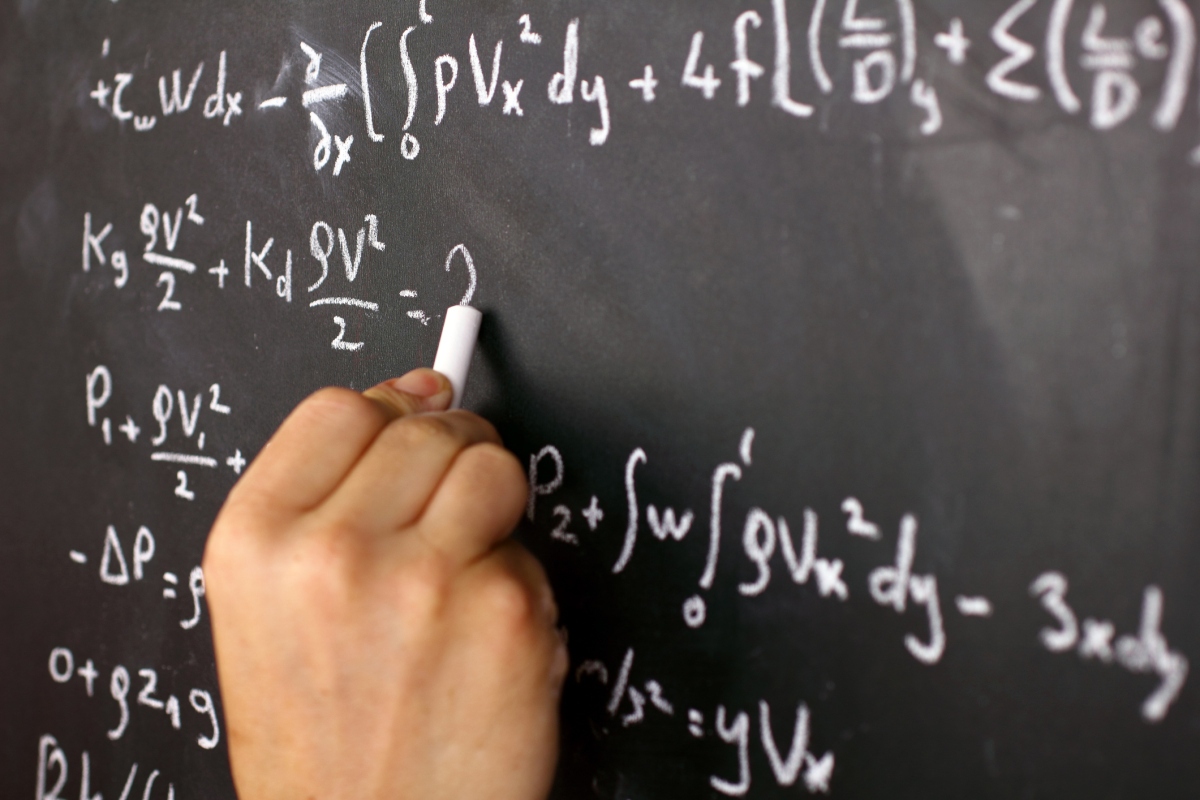
Sulle nostre origini sappiamo davvero poco. Ma non ci riferiamo al fatto che discendiamo dalla scimmia o da un’altra specie, bensì al perché la vita abbia avuto inizio su questo pianeta. Una questione che ha cercato di risolvere lo studio di Robert G. Endres, dell’Imperial College di Londra, ma che ha solo sollevato molte più domande e lasciato l’amaro in bocca, perché secondo i suoi risultati la vita non avrebbe dovuto nascere.
Applicando la matematica, quella branca della scienza che molti odiano, si è giunti a una conclusione molto chiara: le barriere che impediscono alla vita di nascere spontaneamente sono “formidabili”. Talmente formidabili, infatti, che le probabilità che ciò accadesse per puro caso nel lasso di tempo disponibile sulla Terra primitiva sono incredibilmente basse, ovvero sarebbe stato logico che la vita non fosse mai nata.
L’approccio di Endres mette da parte le provette e si concentra sulle informazioni. Una cellula non è solo un “sacco di molecole”; è un sistema altamente strutturato e orchestrato nel tempo e interconnesso. La domanda è: quante informazioni sono necessarie per “scrivere” la prima protocellula che ha dato origine alla vita?
Per stimarlo, lo studio ricorre a modelli computazionali moderni e strumenti di IA che già utilizziamo oggi, come AlphaFold (per il ripiegamento delle proteine) e modelli completi di “cellula intera”. Il risultato in questo caso era suddiviso in tre parti diverse:
- Le informazioni genetiche per una cellula molto semplice come il Mycoplasma genitalium occupano 10⁶ bit, che è piuttosto poco.
- Le informazioni strutturali, ovvero il modo in cui si ripiegano le proteine e si organizza la cellula, sono stimate anch’esse in un intervallo compreso tra 10⁶ e 10⁸ bit.
- Infine, le informazioni dinamiche, che si concentrano sui percorsi metabolici, la segnalazione o i meccanismi di replicazione del DNA, sono senza dubbio enormi. In questo caso è stato dato un valore di 140 MB in questo mondo che è stato generato.
Sommando tutto ciò, la complessità di una semplice protocellula è stata stimata in 1 miliardo di bit nel paragone con il software. E questo è il muro che la chimica prebiotica ha dovuto finire per scalare.
Una volta che si dispone di tutte le informazioni teoriche, è qui che la matematica diventa molto interessante, soprattutto se si considera che la Terra ha avuto a disposizione una “finestra” temporale di 500 milioni di anni per accumulare tutte queste informazioni fino alla comparsa della prima protocellula. Con un semplice calcolo, se si divide l’informazione necessaria (10000000000 bit) per il tempo disponibile, si ottiene che il tasso minimo di accumulo di informazioni è di 2 bit di informazioni utili all’anno.
Visto così, sembra facilissimo! Lo studio stima che il “brodo” prebiotico, ricco di molecole complesse, avesse un potenziale di generazione di informazioni di circa 100 bit/s, miliardi di volte superiore al necessario, secondo le stime matematiche. Allora… dov’è il problema se c’era tempo in abbondanza?
Il problema è che questi “2 bit all’anno” sono considerati come un processo unidirezionale e progressivo. Cioè, quando viene creato quel pezzo di informazione utile, viene conservato e utilizzato per il passo successivo. Ma la chimica è una zuppa caotica che non funziona così, ma funziona come una “passeggiata casuale”: si fa un passo avanti e subito dopo se ne fa un altro indietro. In altre parole, il momento in cui si crea qualcosa è accompagnato da una perdita.
È qui che entra in gioco il concetto di “persistenza”, che in sostanza è il tempo in cui il sistema “ricorda” le informazioni che ha acquisito, anche se le ha perse. In questo modo, senza un’immensa persistenza, secondo questo studio la nascita della vita sarebbe letteralmente impossibile.
Ma secondo la matematica, in un brodo così caotico come questo, la realtà è che lasciare tutto al caso avrebbe fatto sì che non saremmo mai potuti apparire su questo pianeta. E questo è il vero mistero. Perché noi fossimo qui, doveva esistere un principio fisico, un bias chimico o un meccanismo di “memoria” o “ritenzione” che desse direzionalità al processo.
Lo studio non dice che la vita sia impossibile, ma che il meccanismo puramente casuale è insufficiente. Abbiamo bisogno di “principi fisici sconosciuti” o, come sottolinea l’autore, “una qualche forma di struttura informativa prebiotica”.
Ed è qualcosa che viene proposto in altri studi, come quello di Chrostoph Adami che si è concentrato sul tentativo di comprendere gli esseri viventi come catene di informazioni autosufficienti per cercare la probabilità che la vita nasca in modo statistico. E anche in questo caso la probabilità è molto bassa.
A questo punto del mistero, l’articolo menziona con cautela l’ipotesi alternativa: la panspermia guidata. Proposta originariamente da Francis Crick (lo scopritore del DNA) e Leslie Orgel, suggerisce che una civiltà extraterrestre avanzata abbia intenzionalmente “seminato” la vita sulla Terra. Sebbene questa idea violi il rasoio di Ockham (la spiegazione più semplice è solitamente quella corretta), l’autore ammette che rimane un’alternativa “logicamente aperta”.
L’IA ha avuto molto da dire, poiché grazie alle sue capacità è stato possibile stimare la complessità algoritmica della cellula che ha dato origine alla vita, fornendoci la portata del problema. E l’autore sottolinea che l’IA potrebbe anche essere la chiave per la soluzione, poiché propone strumenti che potrebbero “aiutare a applicare il reverse engineering ai percorsi candidati”. In altre parole, potrebbe essere quella che alla fine troverà quella “spinta” che al momento non conosciamo.