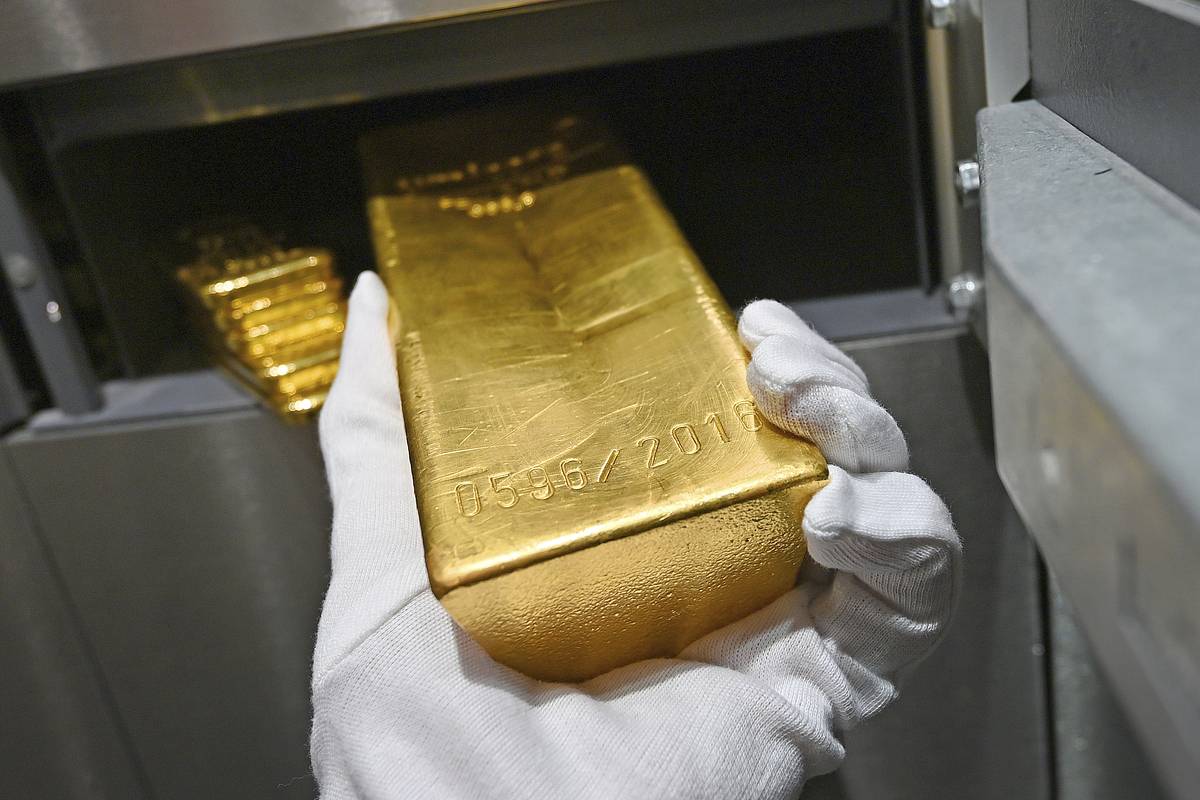Nel 24 a.C., il geografo greco Strabone visitò la Valle dei Re, una zona scoscesa nelle vicinanze dell’antica capitale di Tebe dove erano concentrate le tombe dei faraoni d’Egitto, e riuscì ad entrare nella maggior parte delle sepolture della necropoli reale. Di queste, 40 erano aperte e le mummie e i corredi funerari erano scomparsi per mano dei numerosi gruppi di saccheggiatori di tombe che operavano in quel luogo da secoli; non erano serviti a nulla i metodi di protezione delle tombe reali che i sovrani egizi avevano introdotto durante il Nuovo Regno, millecinquecento anni prima.
Le piramidi nel mirino: perché nemmeno trappole ingegnose sono riuscite a fermare i saccheggiatori di tombe

Ma la pratica della profanazione delle tombe era molto più antica: risale agli albori della civiltà egizia. Gli archeologi hanno verificato che le sepolture erano già state saccheggiate in epoca predinastica, intorno al 3000 a.C., alla ricerca degli oggetti che costituivano il corredo funerario del defunto, dal cibo e dai mobili ai gioielli e agli effetti personali. Il furto dalle tombe era così comune che persino un paragrafo del Libro dei Morti (un testo di carattere funerario composto a partire dal 2100 a.C.) fa riferimento al problema: «Non ho rubato il cibo dei morti né ho toccato le bende [che avvolgono le mummie]».
Gli abitanti del Nilo escogitarono diversi metodi per evitare questi saccheggi. Il principale consisteva nel progettare all’interno delle tombe sotterranee un complesso sistema di stretti passaggi che conducevano a camere senza uscita o a porte bloccate con lastre di granito. Ma nemmeno questo fermò i ladri, che saccheggiarono tutte le piramidi dei faraoni fin dai tempi più remoti, come raccontavano gli stessi egiziani: «Colui che era sepolto come Falco [il faraone] viene strappato dal suo sarcofago. Il segreto delle piramidi è violato», si legge in un frammento appartenente a un’opera letteraria della fine dell’Impero Antico, Le lamentazioni di Ipu-ur. In questo difficile periodo, il saccheggio delle tombe era all’ordine del giorno e questo documento racconta la più antica profanazione di cui si abbia traccia scritta.
Nessuna tomba era al sicuro
Durante l’Impero Medio, i faraoni cercarono di impedire questi furti, ma senza successo. Furono i re della XVIII dinastia a ideare un nuovo sistema per proteggere le loro tombe. Da un lato, il luogo di sepoltura del faraone fu separato dal tempio dedicato al suo culto funerario. Questi templi erano situati in bella vista, di fronte alla nuova capitale, Tebe: sulla riva occidentale del Nilo, in una zona di transizione tra la zona montuosa e i campi coltivati lungo il fiume. La necropoli con le tombe reali, invece, era situata dietro quella zona, in quella che oggi conosciamo come la Valle dei Re, una valle nascosta tra alte scarpate.
Per rendere meno evidente l’ubicazione delle loro tombe, i faraoni si facevano seppellire in ipogei scavati nella montagna, abbandonando la struttura piramidale. L’ingresso a queste tombe rupestri non era contrassegnato da alcun segno, quindi era difficile capire se si trattasse di una grotta naturale o di una costruzione umana.
I Medjai, un corpo speciale di polizia costituito da mercenari di origine nubiana, proteggevano l’intera zona. E, per maggiore sicurezza, gli operai che costruivano queste tombe vivevano concentrati in un villaggio, Deir el-Medina, dal quale praticamente non uscivano. Tutto questo per evitare che le tombe dei sovrani fossero saccheggiate. Ma i ladri riuscirono a eludere tutte le misure di sicurezza.
Rubati durante la sepoltura
Sebbene i saccheggiatori potessero agire in qualsiasi momento, lo fecero soprattutto in periodi di incertezza politica, come indicano le prove archeologiche e i racconti dei papiri. Questo fu il caso della fine della XVIII dinastia. Allora, la rivoluzione religiosa promossa dal faraone eretico Akhenaton e il ritorno al culto tradizionale sotto Tutankhamon segnarono un periodo instabile, durante il quale si verificarono tentativi di furto nelle tombe di Amenhotep III, Thutmose IV e dello stesso Tutankhamon.
Il faraone Horemheb pose fine a questo ciclo ordinando la riparazione delle tombe, come indicano i sigilli con il suo nome che appaiono su alcune di esse. Alla fine della XX dinastia, un periodo segnato dalla corruzione nell’amministrazione, dalle incursioni dei Libici nel Delta e persino da scioperi dei lavoratori della necropoli reale causati dalla fame, le tombe della Valle dei Re furono nuovamente oggetto di furti.
Probabilmente, la maggior parte dei furti avveniva durante la sepoltura stessa o poco dopo la deposizione del corpo nella tomba; in questi casi, i ladri contavano senza dubbio sulla collaborazione dei costruttori della tomba e persino sull’aiuto delle guardie della necropoli. La disposizione degli elementi della tomba permette di capire se il furto è stato compiuto al momento della sepoltura. In tal caso, la porta della tomba appare chiusa, mentre all’interno la mummia si trova fuori dal sarcofago e i materiali del corredo funerario sono rotti e sparsi.
A volte, i ladri agivano anche al momento della mummificazione, poiché le bende del corpo appaiono spesso strappate e non si trovano gli amuleti che dovrebbero essere presenti tra di esse. Oltre a questi amuleti, i ladri portavano via tessuti, profumi, cibo, recipienti e mobili in legno o avorio, tutti oggetti di uso quotidiano che non attiravano molto l’attenzione. Ma se nei furti erano coinvolti alti ufficiali, venivano sottratti anche gioielli e altri oggetti realizzati con metalli preziosi.
Per molto tempo si è supposto che i furti avvenuti nella Valle dei Re fossero stati perpetrati da personaggi di bassa estrazione sociale. Tuttavia, diversi storici hanno suggerito che durante il Terzo Periodo Intermedio furono gli stessi monarchi a ordinare l’apertura delle tombe per portare via i gioielli d’oro e riutilizzarli nei loro corredi funerari, a causa della scarsità di materiali nobili che accompagnò quel periodo di crisi.
Saccheggi: un business losco

I saccheggi delle tombe non sono noti solo per le prove archeologiche, ma anche per una serie di eccezionali testimonianze scritte. Si tratta di una serie di papiri in scrittura ieratica (derivata dai geroglifici) che raccontano in dettaglio i processi ai ladri delle tombe della Valle dei Re. Questi papiri sono stati trovati nel tempio funerario di Ramses III a Medinet Habu e prendono il nome da diversi studiosi e mecenati: Ambras, Leopold II-Amherst, Harris A, Mayer A e B, e Abbott. I più famosi raccontano alcuni processi contro ladri di tombe che si svolsero al tempo di alcuni faraoni della fine del Nuovo Regno.
Nel sedicesimo anno del regno di Ramses IX (1108 a.C.), il sindaco di Tebe Est denunciò al governatore della città diversi furti di tombe presumibilmente commessi nella Valle dei Re. Il Papiro Abbot contiene una sintesi del processo condotto dallo stesso governatore.
A quel tempo, la corte si trovava nella città di Pi-Ramses, nel Delta, anche se i faraoni continuavano a essere sepolti nella Valle dei Re, a Tebe. Durante il regno di Ramses IX, Tebe era governata dal visir Jaemuaset; sotto il suo comando c’erano il sindaco di Tebe Est, chiamato Paser, e Pauraa, il responsabile di Tebe Ovest. La necropoli reale era sorvegliata dai medyai, controllati da Pauraa, che era il capo della polizia. A un certo punto, Paser sentì voci di furti nella necropoli reale e accusò diversi lavoratori, che si difesero dicendo che le tombe erano già state aperte.
Il visir ordinò di esaminare dieci tombe reali; verificò che sette erano intatte, mentre in altre due si notavano tentativi di saccheggio (quelle di Inyotef V e VI, della XVII dinastia) e solo quella di Sebekemsaf II era stata violata. Pauraa fornì un elenco di sospetti che furono interrogati e torturati, ma solo la banda di un certo Amonpanefer ammise il furto di una tomba reale.
Amonpanefer fece una confessione completa: «Abbiamo preso i nostri attrezzi di rame e abbiamo scavato un passaggio nella piramide-tomba del re, abbiamo trovato la camera sotterranea e siamo scesi con le nostre torce in mano, e abbiamo trovato la tomba della regina, abbiamo aperto i suoi sarcofagi e le bare dove riposavano e abbiamo trovato la nobile mummia di questo re, equipaggiato con una spada jepesh; intorno al collo aveva molti amuleti e gioielli d’oro. Era coperto dalla sua maschera d’oro.
La venerabile mummia del re era interamente ricoperta d’oro. Le sue bare erano decorate con argento e oro sia all’interno che all’esterno e ricoperte di ogni tipo di pietre preziose. Strappammo via l’oro, trovammo la regina nelle stesse condizioni e strappammo via anche tutto ciò che la ricopriva, poi appiccammo il fuoco alle sue bare. Nonostante questa dichiarazione incriminante, Amonpanefer fu rilasciato, poiché è molto probabile che Pauraa abbia corrotto i membri della commissione.
L’interno del tempio di Abu Simbel fu saccheggiato nella confusione che seguì l’invasione persiana dell’Egitto. Abbandonato e ricoperto di sabbia, non fu scoperto fino al 1817. Sala d’ingresso al tempio in una litografia di David Roberts, 1846, Biblioteca del Congresso.
Questo non fu l’unico processo celebrato durante il regno di Ramses IX. Nel diciannovesimo anno del suo regno ci fu un’altra indagine per furti nelle tombe di Seti I e Ramses II che si concluse con l’arresto di cinque persone di umili origini. Le liste dei sospettati che furono redatte ci mostrano il coinvolgimento nella vicenda di personaggi di tutte le classi sociali: scribi, commercianti, schiavi di funzionari, guardiani e barcaioli.
Alcuni anni dopo, sotto il regno dell’ultimo faraone del Nuovo Regno, Ramses XI, anch’esso segnato da disordini e instabilità politica, si verificarono nuovi saccheggi di tombe. Il Papiro Mayer B racconta il processo a una serie di ladri che penetrarono nella tomba di Ramses VI e descrive in dettaglio ciò che portarono via, tra utensili di metallo e tessuti.
Una punizione terribile
I ladri di tombe erano esposti alla giustizia implacabile del faraone. Per estorcere loro una confessione si ricorreva a diversi metodi di tortura, in particolare le percosse con bastoni. Una volta dimostrata la loro colpevolezza, venivano condannati a diverse pene, la più comune delle quali era la mutilazione delle orecchie, del naso e di altre parti del viso. Nel caso in cui il ladro avesse distrutto il cadavere della tomba saccheggiata, specialmente se lo aveva bruciato, subiva la punizione massima: veniva impalato e il suo nome veniva cancellato dalla tomba, impedendogli così di avere una vita nell’Aldilà, poiché per gli egizi la conservazione del nome era importante quanto quella del corpo.
Vista aerea della necropoli reale di Tebe, sulla riva occidentale del Nilo. Nemmeno questo luogo remoto fu al riparo dall’avidità e dall’abilità dei saccheggiatori di tombe.
iStock
I furti nelle tombe continuarono per tutta la storia dell’Egitto. In epoca greca e romana, le tombe erano già state aperte, come indicano le iscrizioni in greco e latino che sono state trovate al loro interno, così come la presenza di croci copte realizzate durante il periodo cristiano. E la presenza di graffiti moderni ci ricorda che i ladri continuano a saccheggiare le necropoli ancora oggi. Ma non tutti i ladri sono riusciti a fuggire senza essere catturati.
In una tomba romana a Dush è stato trovato uno scheletro accanto a una lettera del XVIII secolo riguardante l’approvvigionamento di erba per un asino; una roccia della volta era caduta sul ladro uccidendolo. Casualità o giustizia divina?