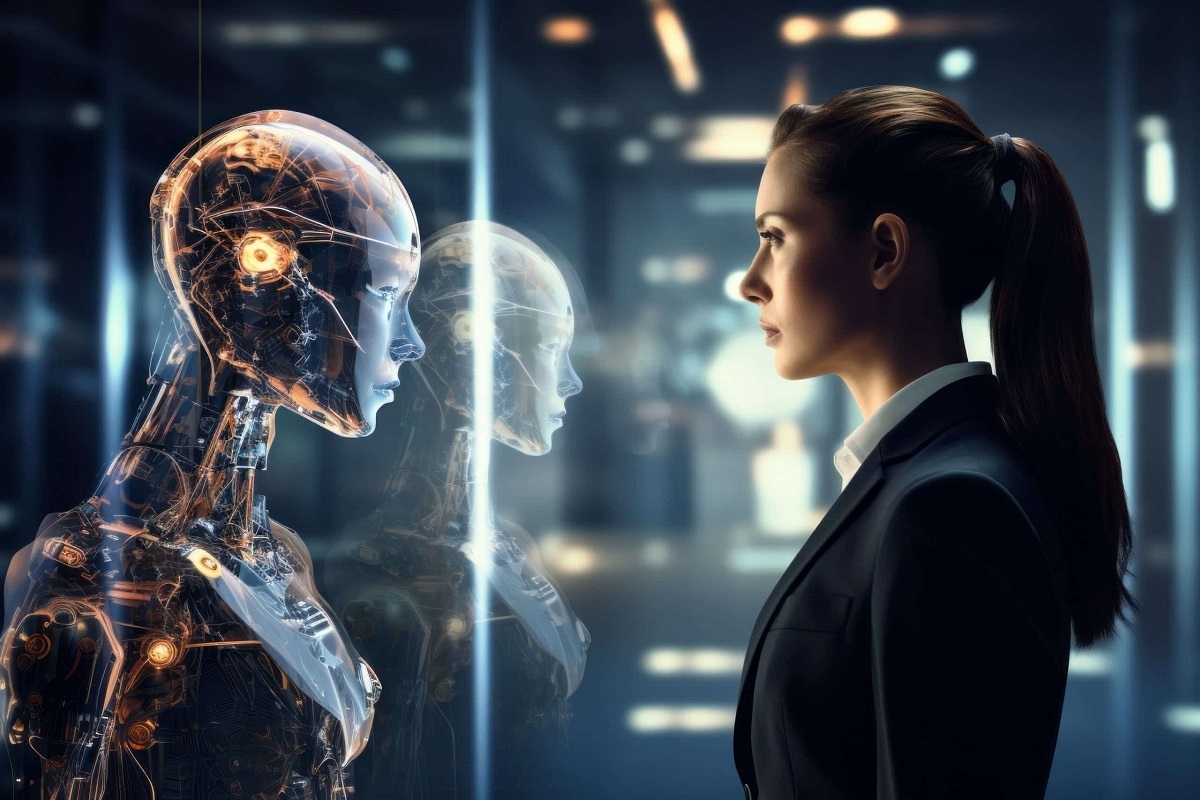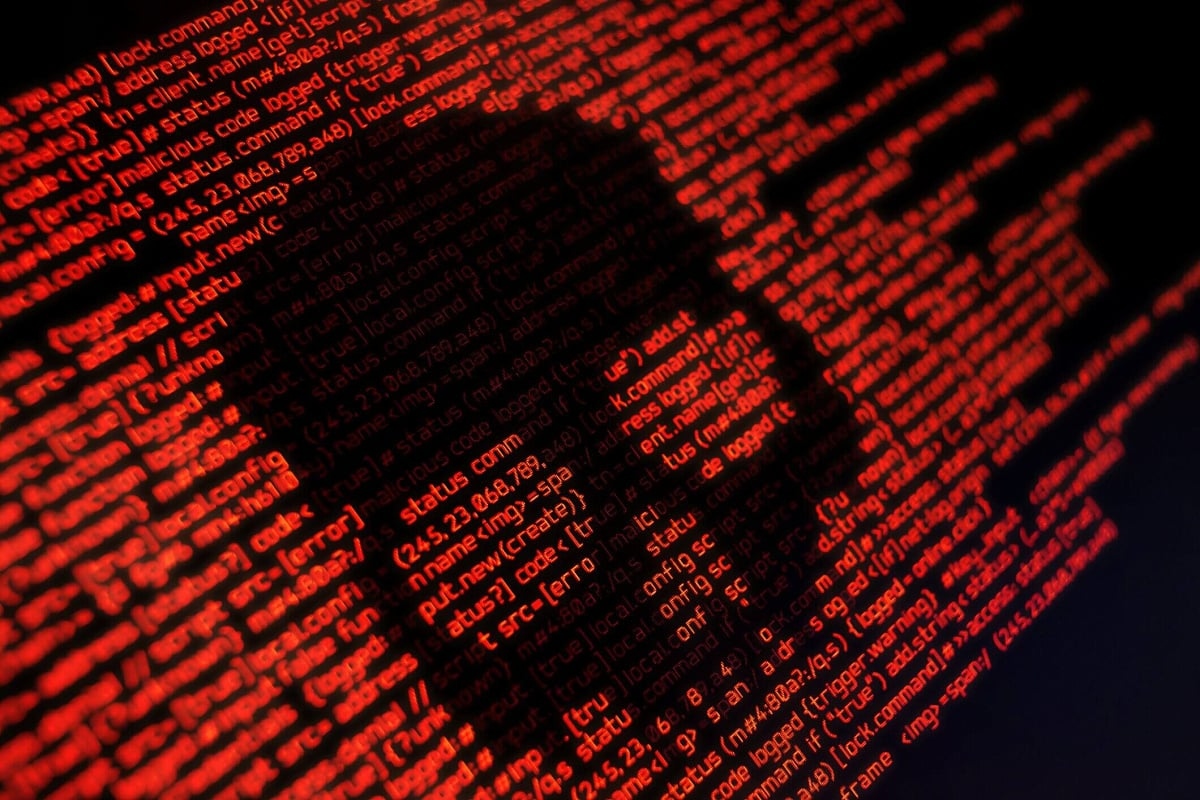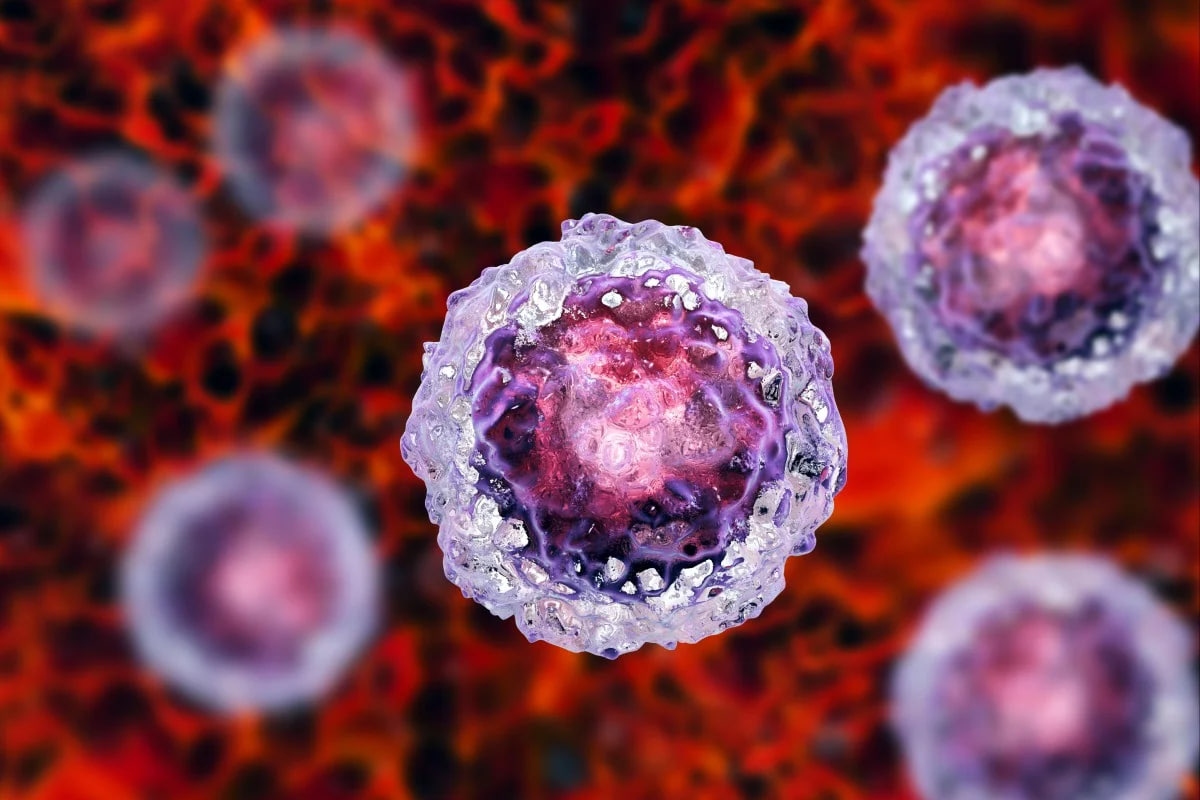Lo ha evidenziato l’analisi dell’ingegneria del contesto, una disciplina che ha acquisito importanza negli ultimi anni e che, secondo quanto dettagliato in uno studio intitolato “Ingegneria del contesto 2.0: Il contesto dell’ingegneria del contesto”, pubblicato su AV costituisce la vera sfida nell’interazione tra esseri umani e macchine. Lungi dall’essere un’innovazione recente, l’ingegneria del contesto affonda le sue radici in oltre due decenni di evoluzione tecnologica e oggi si profila come la chiave per consentire ai sistemi intelligenti di interpretare e anticipare le intenzioni umane. E su questo punto si concentra lo studio, che è un preprint (cioè non ancora sottoposto a revisione paritaria).
Il contesto come interfaccia reale nell’interazione uomo-macchina

Come spiegato dallo studio, il contesto è molto più della cronologia di una conversazione o dei dati che un utente inserisce in un’applicazione. È l’insieme delle informazioni che caratterizzano la situazione di tutti gli elementi coinvolti in un’interazione, dall’utente e dall’applicazione all’ambiente, ai dispositivi e ai servizi connessi.
La difficoltà sta nel fatto che, mentre le persone sono in grado di dedurre informazioni non esplicite e colmare le lacune grazie alla loro esperienza e conoscenza condivisa, le macchine non hanno questa capacità.
Pertanto, l’ingegneria del contesto diventa il processo di trasformazione di contesti complessi e ambigui in rappresentazioni che le macchine possono comprendere e utilizzare.
Il rapporto ha sottolineato che la vera interfaccia tra esseri umani e macchine non è il “prompt” o l’istruzione diretta, ma il contesto in cui avviene l’interazione. “Una persona è la somma dei suoi contesti”, hanno affermato gli autori, sottolineando che l’essenza di una comunicazione efficace risiede nella capacità di ridurre l’entropia delle informazioni in modo che la macchina possa agire in accordo con l’intenzione umana.
Definizione e fondamenti dell’ingegneria del contesto
L’ingegneria del contesto, come definita dal documento, è il processo sistematico di progettazione e ottimizzazione della raccolta, dell’archiviazione, della gestione e dell’utilizzo del contesto per migliorare la comprensione e le prestazioni delle macchine nei loro compiti.
Questo approccio non si limita a una tecnologia specifica o a un’epoca particolare: spazia dai computer primitivi degli anni Novanta agli attuali agenti intelligenti e ai sistemi che si intravedono nel futuro.
Il processo implica diverse operazioni chiave:
1. Raccogliere informazioni contestuali rilevanti tramite sensori o canali diversi.
2. Archiviare e gestire tali informazioni in modo efficiente e sicuro.
3. Rappresentare il contesto in formati interoperabili e coerenti.
4. Elaborare input multimodali (testo, audio, immagini, ecc.).
5. Integrare e riutilizzare contesti passati per arricchire la memoria del sistema.
6. Selezionare gli elementi contestuali più pertinenti per ogni compito.
7. Condividere il contesto tra agenti o sistemi.
8. Adattare il contesto in modo dinamico in base all’apprendimento e al feedback.
Questo quadro teorico consente di collegare le pratiche attuali, come l’ingegneria delle istruzioni o la generazione aumentata dal recupero, con i fondamenti storici dell’interazione uomo-computer.
Evoluzione storica: dall’informatica primitiva agli agenti intelligenti
Il percorso storico dell’ingegneria del contesto, come dettagliato nello studio, si articola in quattro grandi fasi, ciascuna caratterizzata dal livello di intelligenza delle macchine:
1. Era 1.0: Informatica primitiva (1990-2020).
In questa fase, i sistemi potevano elaborare solo input strutturati e segnali semplici. Gli utenti dovevano adattare le loro intenzioni a formati rigidi e i progettisti fungevano da traduttori delle intenzioni umane in istruzioni comprensibili per la macchina. L’interazione si basava su menu, sensori di base e regole predefinite.
2. Era 2.0: Intelligenza incentrata sugli agenti (2020-oggi).
Con l’avvento dei modelli linguistici e degli agenti intelligenti, le macchine hanno iniziato a interpretare il linguaggio naturale e a gestire l’ambiguità. Ora i sistemi possono collaborare con gli utenti, interpretare intenzioni implicite e gestire contesti più ricchi e vari, inclusi testo libero, immagini e dati provenienti da sensori avanzati.
3. Era 3.0: Intelligenza a livello umano (futuro prossimo).
Si prevede che i sistemi raggiungeranno una comprensione del contesto paragonabile a quella umana, integrando segnali sociali, emozioni e dinamiche ambientali complesse. La collaborazione tra esseri umani e macchine sarà più fluida e naturale.
4. Era 4.0: Intelligenza sovrumana (futuro speculativo).
In questo scenario, le macchine non solo comprenderanno il contesto, ma saranno in grado di anticipare bisogni non espressi e costruire nuovi contesti per gli esseri umani, invertendo il rapporto tradizionale e diventando fonti di ispirazione e conoscenza.
Strategie attuali di raccolta, gestione e utilizzo del contesto

La moderna ingegneria del contesto ha sviluppato una serie di strategie per raccogliere, archiviare e utilizzare le informazioni contestuali in modo efficiente. Secondo la ricerca divulgata come preprint, queste sono alcune delle pratiche più rilevanti:
- Raccolta e archiviazione distribuita: il contesto non è più limitato a un singolo dispositivo, ma viene raccolto tramite smartphone, smartwatch, sensori domestici e servizi cloud. L’archiviazione è organizzata in livelli, distinguendo tra memoria a breve e lungo termine, e viene data priorità alla sufficienza e alla continuità semantica rispetto al volume dei dati.
- Elaborazione testuale e multimodale: i sistemi etichettano le informazioni con marcatori temporali, ruoli funzionali o attributi semantici e applicano tecniche di compressione tramite sintesi, schemi strutturati o vettori semantici. L’integrazione di diverse modalità (testo, immagine, audio) avviene tramite spazi vettoriali condivisi e meccanismi di attenzione incrociata.
- Organizzazione gerarchica della memoria: ispirandosi alla memoria umana, i sistemi separano le informazioni recenti e rilevanti (memoria a breve termine) dalle conoscenze stabili e astratte (memoria a lungo termine), trasferendo i dati tra i livelli in base alla loro importanza e frequenza di utilizzo.
- Isolamento e condivisione del contesto: per evitare la contaminazione della memoria e migliorare l’efficienza, vengono utilizzati subagenti con contesti isolati e riferimenti leggeri alle informazioni memorizzate esternamente. Inoltre, gli agenti possono condividere il contesto tramite messaggi strutturati, memoria condivisa o sintesi in linguaggio naturale.
- Selezione e filtraggio adattivo: poiché non tutte le informazioni sono rilevanti per ogni attività, i sistemi applicano filtri basati sulla rilevanza semantica, la dipendenza logica, l’attualità, la frequenza e le preferenze dell’utente, riducendo al minimo la ridondanza e il rumore.
- Inferenza proattiva delle esigenze: oltre a rispondere a istruzioni esplicite, gli agenti intelligenti analizzano modelli di comportamento, preferenze e sequenze di domande per anticipare obiettivi nascosti e offrire assistenza in modo proattivo.
Sfide tecniche e prospettive future nell’ingegneria del contesto
Nonostante i progressi, l’ingegneria del contesto deve affrontare sfide significative. Tra le principali sfide figurano:
- Limiti nella raccolta del contesto: la dipendenza dall’input esplicito dell’utente rimane un ostacolo e sono necessari metodi più naturali e multimodali per cogliere lo stato e le intenzioni delle persone.
- Gestione di grandi volumi di contesto: la crescita esponenziale delle informazioni accumulate pone problemi di archiviazione, organizzazione e recupero efficiente, nonché di coerenza e aggiornamento nel tempo.
- Comprensione limitata da parte dei modelli: le macchine non raggiungono ancora il livello di ragionamento e comprensione contestuale degli esseri umani, specialmente in compiti che richiedono una logica complessa o l’interpretazione di relazioni in immagini e altri formati.
- Colli di bottiglia delle prestazioni con contesti lunghi: le architetture attuali, come i trasformatori, presentano difficoltà nell’elaborare contesti estesi in modo efficiente e affidabile, limitando la scalabilità dei sistemi.
- Selezione accurata del contesto rilevante: filtrare e dare priorità alle informazioni utili rimane una sfida, poiché i sistemi possono trascurare segnali importanti o mantenere dati ridondanti.
Il futuro dell’ingegneria del contesto punta alla creazione di sistemi in grado di gestire il contesto in modo autonomo, dinamico e spiegabile, con architetture che consentano una memoria semantica robusta e un adattamento continuo.
L’obiettivo è che le macchine non solo comprendano gli esseri umani, ma contribuiscano anche ad aiutare le persone a comprendere meglio i propri processi e le proprie esigenze.
L’ingegneria del contesto si consolida come il pilastro su cui sarà costruita la prossima generazione di intelligenza artificiale.
Man mano che i sistemi intelligenti si avvicineranno – e forse supereranno – la cognizione umana, non solo saranno in grado di capirci, ma potranno anche aiutarci a scoprire nuove dimensioni della nostra identità e conoscenza.