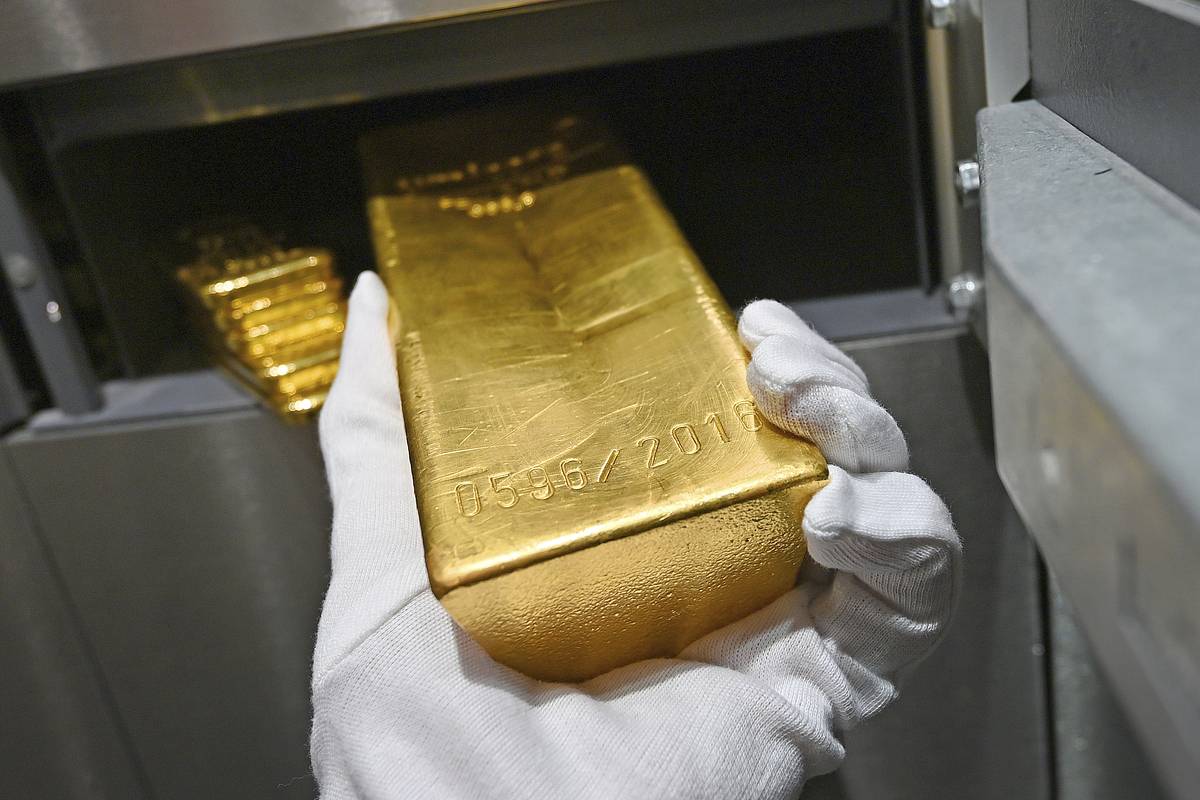È successo più di 70 anni fa ad Ártánd, al confine tra Ungheria e Romania. Intorno al 1953, alcuni lavoratori dell’area di estrazione della sabbia di Zomlinpuszta trovarono per caso una serie di oggetti metallici di eccezionale qualità. Si trattava del tesoro di Ártánd, uno dei ritrovamenti archeologici più singolari dell’età del ferro in Europa. Decenni dopo, le analisi condotte dagli studiosi hanno permesso di comprendere la reale portata e unicità del ritrovamento. Si tratta di un corredo funerario risalente alla seconda metà del VI secolo a.C. e legato alle élite guerriere della cultura di Vekerzug. Il tesoro si distingue sia per la singolarità degli oggetti che contiene sia per la sua genesi: infatti, è il risultato di una complessa rete di influenze culturali che collegava il Mediterraneo arcaico con il bacino carpato. Combina così pezzi di origine e stile greco, italico, balcanico e locale, testimonianza di un’epoca di intensi scambi e gerarchie emergenti.
Un ritrovamento casuale di grande rilevanza archeologica

Il complesso è stato scoperto a metà del XX secolo in un sito vicino all’attuale località di Ártánd, nella contea ungherese di Hajdú-Bihar. Gli operai hanno trovato gli oggetti mentre scavavano in un deposito alluvionale del fiume Körös, un punto in cui già negli anni Trenta erano stati rinvenuti alcuni pezzi isolati.
Secondo testimonianze successive, il primo oggetto recuperato fu una hidria di bronzo di origine greca, seguita da un calderone con manici a croce che conteneva i pezzi di un’armatura a scaglie. La coerenza interna degli oggetti, così come i parallelismi culturali, hanno permesso di datare con certezza il complesso al VI secolo a.C.
Sebbene non siano stati trovati resti umani, tutte le indicazioni suggeriscono che i pezzi appartenevano a un contesto funerario di inumazione. Secondo Bence Soós, autore di un recente studio sul complesso, gli oggetti sarebbero appartenuti a una tomba principesca, forse di un capo o di un guerriero di alto rango delle comunità del Vekerzug.
L’idria greca e i vasi di bronzo
Uno degli oggetti più importanti del tesoro è l’idria arcaica in bronzo, attribuita a una bottega laconica, forse spartana, dell’inizio del VI secolo a.C. La sua decorazione con protomi di serpente e un terminale a forma di testa d’anatra la collega agli esemplari del gruppo di Telesstas. È, ad oggi, l’unica idria greca in bronzo conosciuta nel bacino carpato, prova tangibile dell’esistenza di contatti a lunga distanza con il mondo ellenico.
Il secondo grande recipiente, un calderone di bronzo con manici a forma di croce, mostra segni di riparazione con lamine rivettate. Ciò suggerisce un uso prolungato prima della sua deposizione nella tomba. Questo pezzo, probabilmente fabbricato nel nord Italia o in Slovenia, rappresenta il collegamento occidentale del complesso e suggerisce che gli oggetti di prestigio circolavano tra le élite danubiane e alpine.
L’armamento e il potere del guerriero
Il contenuto del calderone ha fornito informazioni fondamentali per interpretare il ritrovamento. Al suo interno sono state rinvenute lamine di ferro e bronzo appartenenti a un’armatura a scaglie, un indumento da combattimento di alto rango associato alle élite militari dal VII secolo a.C. Párducz lo ha collegato alle tradizioni scite, anche se studi recenti dimostrano che questo tipo di armatura si diffuse anche tra i gruppi di Hallstatt della Pannonia meridionale e dei Balcani.
Il complesso era inoltre accompagnato da un pomello di scudo in bronzo di tipo balcanico, simile agli esemplari di Donja Dolina e Atenica, e da un’ascia di ferro simile a quelle rinvenute a Regöly o Somló, associate alle aristocrazie transdanubiane. Una lancia di ferro di 49 cm completava l’eccezionale panoplia guerriera.
La combinazione dell’idria, del calderone, dell’armatura e delle armi compone un’immagine cerimoniale di potere che trascende l’ambito militare. Secondo Soós, il defunto sarebbe stato rappresentato come un signore della guerra in connessione con le tradizioni eroiche del Mediterraneo e della steppa.
Il cavallo e i simboli di prestigio

Tra i pezzi più significativi figurano anche diversi elementi appartenenti a finimenti equestri, come un morso in ferro di tipo Vekerzug e diverse falle in bronzo decorate con motivi conici, fungiformi o zoomorfi. Questi oggetti rafforzano l’interpretazione dell’insieme come corredo di un guerriero a cavallo, figura centrale nella gerarchia della cultura di Vekerzug, dove il cavallo simboleggiava sia il rango che il legame con il divino.
La diversità delle forme e delle tecniche delle falere, dal canto suo, mostra la convergenza di influenze provenienti dalla Transilvania, dai Balcani e dall’Adriatico. In questo modo, il guerriero di Ártánd era rappresentato come un cavaliere aristocratico, depositario di un’identità ibrida che combinava elementi locali, balcanici e greci.
Il tesoro d’oro: diademi e ornamenti
Il ritrovamento comprendeva anche una notevole collezione di gioielli in oro. Gli archeologi sono riusciti a recuperare un frammento di diadema decorato con motivi a lira e rosoni, oltre 130 applicazioni a forma di rosone, anelli con granitura e perline biconiche in lamina d’oro. Sebbene la dispersione dei pezzi impedisca di ricostruire la disposizione originale, la loro omogeneità tecnica suggerisce che facessero parte di un ornamento corporeo o di un copricapo femminile, forse appartenente a una figura associata al guerriero.
I confronti con i corredi funerari di Atenica (Serbia) e Stična (Slovenia) rivelano lo stesso linguaggio visivo d’élite che combinava l’uso dell’oro, la decorazione con simboli vegetali e le forme geometriche. La diadema di Ártánd, in particolare, non ha paralleli esatti nel bacino carpato. La sua fattura suggerisce l’influenza di orafi del nord del Mar Nero o di laboratori traci.
Il significato storico di una scoperta unica
Le analisi di Bence Soós collocano il deposito del complesso verso il secondo o terzo quarto del VI secolo a.C. Questo orizzonte coincide con l’espansione delle élite hallstattiane dell’Europa sud-orientale e con il consolidamento delle reti di scambio tra l’Adriatico, i Balcani e il basso Danubio.
In questo contesto, il tesoro di Ártánd viene interpretato come un’espressione regionale del modello di tomba principesca hallstattica, sebbene adattato al linguaggio simbolico proprio della cultura Vekerzug orientale. L’assenza di oggetti decorati nello stile animale tipico degli Sciti, così frequenti in altri contesti contemporanei, rafforza l’idea che, ad Ártánd, l’élite cercasse di differenziarsi dai modelli steppici attraverso l’uso di riferimenti occidentali e mediterranei.